
07 Aprile 2025
di Andrea Campinoti
Capita di ascoltare conversazioni di anziani che discutono tra chi ha già acquistato un telefono di quelli ‘che si strusciano’ e coloro che ribadiscono quanto un telefono ‘a tasti’ per loro sia più che sufficiente. In queste ‘dispute’ sono contenute tutte le opportunità ma anche tutte le minacce che l’avvento della digitalizzazione comporta. Da un lato non vi è dubbio che poter disporre di strumenti di connessione più avanzati consente di ampliare in maniera significativa sia le opportunità di comunicazione che di supporto di cui una persona anziana può disporre. Dall’altro questo comporta una serie di rischi legati alle truffe telematiche e non, al rischio di stili di vita più sedentari, alla sottrazione di dati sensibili per un utilizzo a fini commerciali, all’isolamento e alla perdita delle competenze sociali (come stiamo apprendendo nelle nuove generazioni). Come sempre è accaduto nella storia umana, non è quindi la tecnologia di per sé ad essere ‘buona’ o ‘cattiva’, ma l’utilizzo che di questa ne viene fatto.
Se la popolazione anziana non è in sé omogenea, anche a livello di gruppi per classi di età (65/74 anni, 75/84 anni, 85 e più), ulteriori fattori determinano l’approccio verso le nuove tecnologie: il luogo di residenza (urbano, periferico, rurale), la condizione familiare, il titolo di studio, il percorso lavorativo, lo stato di salute. Al netto di queste determinanti vi sono però due dinamiche indiscutibili: la popolazione anziana aumenterà in misura significativa almeno nei prossimi due/tre decenni; i redditi da pensione, come dimostrato durante la pandemia e il ciclo inflazionistico degli anni seguenti, costituiscono un baluardo a difesa del potere di acquisto delle persone (almeno fino ad ora). Non c’è da meravigliarsi dunque che il mercato della silver economy stia sempre di più interessando le imprese for profit e la tecnologia. Ne deriva un importante impulso all’innovazione dei servizi e dei prodotti disponibili, sia nei termini di accessibilità (non si ‘pigia’ o ‘striscia’ più, si parla o addirittura, come ci insegna la tecnologia assistiva, si guarda semplicemente un comando per attivarlo) che di prodotti o servizi disponibili (dalla domotica ai robot sociali). Ma la domanda è: sarà sufficiente la dinamica di mercato (un prodotto o un servizio utile sarà venduto e dunque si diffonderà, uno che non lo è scomparirà in breve) a selezionare i ‘migliori’ supporti per un buon invecchiamento? La risposta a questa domanda, come ci insegna la storia, è che di per sé il mercato – che non è libero in quanto presidiato da posizioni di forza quasi monopolistiche, soprattutto in campo tecnologico e digitale – non è in grado di assicurare questo esito, tutt’altro.
La probabilità che, come abbiamo imparato dalle dinamiche dell’industria farmaceutica, le imprese for profit si concentrino su prodotti, servizi e segmenti di mercato più redditizzi e che lo facciamo cercando di ‘condizionare’ (se non di ‘manipolare’) il comportamento delle consumatrici e dei consumatori, è molto alta. Non saranno dunque né l’innovazione tecnologica (anche legata all’intelligenza artificiale) né tantomeno il ‘mercato’ di per sé a fornirci le chiavi per un buon invecchiamento. Per la longevità sono necessari almeno altri quattro fattori essenziali. Innanzitutto un buon sistema di regolamentazione e vigilanza pubblica rispetto ai prodotti e ai servizi tecnologici che vengono immessi nel mercato ai fini del supporto e della cura degli anziani (tutela della privacy, contrasto alle truffe, corrispondenza a criteri di attendibilità scientificamente dimostrabili – soprattutto per quanto attiene al monitoraggio dello stato fisico e mentale della persona anziana e alle eventuali terapie praticate o somministrate).
In questa direzione non vi è dubbio che l’Europa rappresenti uno dei pochi luoghi al mondo, se non l’unico, dove si provi far qualcosa di significativo in tal senso. In secondo luogo occorre un importante cambiamento delle politiche e dei servizi di welfare pubblico che, soprattutto in Italia, devono superare importanti limiti: la loro strutturazione per comparti o silos (sanitario e sociale nello specifico); la loro eccessiva burocratizzazione (i cui effetti si mostrano nelle percentuali importanti di non take up per molte prestazioni o servizi); una non sempre lineare stratificazione tra livelli e competenze diversi (Stato, Regioni, Enti Locali); il loro orientamento verso l’erogazione di prestazioni monetarie e non di servizi; l’incapacità strutturale di sostenere l’attività di prevenzione; il cronico sotto finanziamento. Il passo in avanti compiuto verso il superamento di alcune di queste criticità con la riforma della non autosufficienza, è stato fortemente limitato dall’uscita dei decreti attuativi, per cui ad oggi queste permangono, con tutto il loro portato negativo sul vissuto di milioni di persone anziane. In terzo luogo è decisivo tornare ad investire sui legami di comunità, a partire dalle infrastrutture fisiche e sociali in cui questi si sostanziano.
Gli spazi pubblici, i circoli, le parrocchie, i pubblici esercizi frequentati da anziani, non sono un fardello di cui disfarsi velocemente in nome di città o paesi più ‘trendy’, ma un patrimonio fondamentale, che può trovare nelle nuove tecnologie importanti opportunità per rinvigorirsi e incrementare il benessere delle persone anziane e il contributo che possono generare per tutta la comunità. Infine il terzo settore e specialmente la cooperazione sociale: formazione, curiosità, l’urgenza di innovarci per essere ancora più utili per le persone anziane e per i loro familiari, devono spingerci ad andare oltre la professionalità che ci contraddistingue, per apprendere e cogliere tutte le opportunità che oggi la tecnologia offre per la cura.
Occorre però anche un ampliamento prospettico: non limitare più il nostro impegno solo verso persone anziane fragili o non autosufficienti, ma attivarsi per la diffusione della longevità nei contesti comunitari e nei vissuti individuali e nello specifico per accompagnare la popolazione anziana ed i caregiver familiari ad un corretto e appropriato utilizzo delle nuove tecnologie. Dobbiamo crescere molto in tal senso. Certo per farlo servono competenze e saperi di cui disponiamo in maniera assai scarsa, complice primo la difficoltà del riconoscimento anche economico di alcune figure professionali altamente specializzate nel nostro comparto lavorativo (sia in campo tecnologico che sanitario). Ma è una strada ineludibile, se vogliamo affermare il nostro protagonismo di portatori di interesse generale e diffuso nella comunità, a fianco delle persone anziane e della loro felicità.
Foto di Gilles Lambert su Unsplash

27 Gennaio 2026
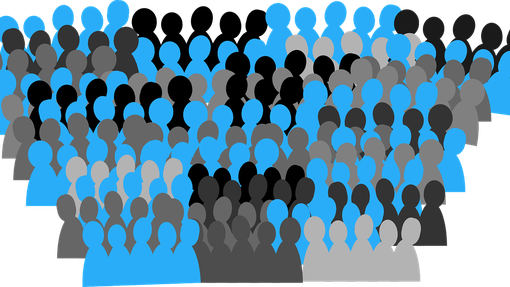
26 Gennaio 2026