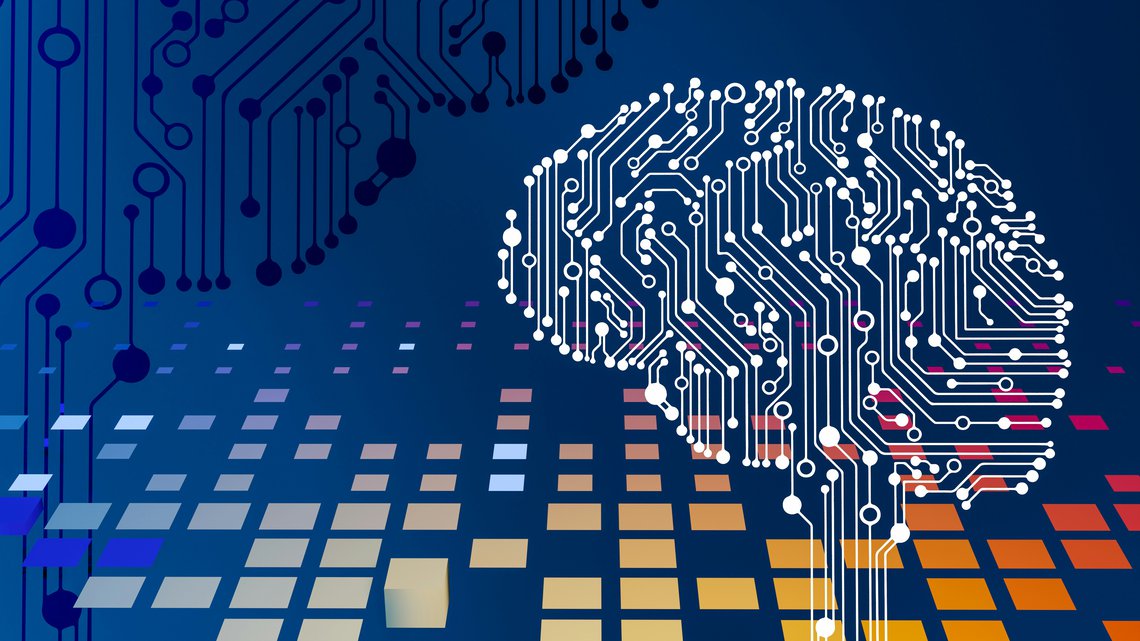
08 Aprile 2025
di Alessandro Logi*
Ormai viviamo in un mondo interamente permeato del digitale, con cui siamo in costante contatto tanto nella vita lavorativa quanto in quella privata.
Abbiamo progressivamente stravolto le nostre abitudini man mano che nuovi device - computer fissi e portatili, tablet, smartphone ecc. - raggiungevano una diffusione capillare nei nostri uffici prima e nelle nostre case poi. Ciò è avvenuto sicuramente in senso positivo, ma anche in senso negativo.
Dobbiamo con urgenza porci certe domande: che cos’è il digitale? perché ha fatto colpo sulla popolazione generale? quali sono i rischi legati a queste tecnologie?
In quanto lavoratori e lavoratrici nell’ambito della cooperazione dobbiamo chiederci: è possibile un utilizzo etico del digitale? oppure dobbiamo buttare tutto alle ortiche?
Il digitale porta con sé importanti problemi etici, sociali, culturali, ambientali e politici.
Per quanto riguarda l’ambiente, il digitale rappresenta una grossa minaccia perché le tecnologie digitali consumano una quantità estremamente elevata di energia elettrica. Da un lato è vero che i nuovi modelli, via via, sono programmati per consumare meno elettricità; dall’altro, però, noi facciamo un uso continuo e spesso spropositato di questi dispositivi. Inoltre, la produzione degli hardware (cioè, della parte fisica del computer) richiede dei materiali particolari - le cosiddette “terre rare” - la cui estrazione e raffinazione ha luogo in aree povere del mondo (Baotou in Cina, Salar de Uyuni in Bolivia o Kolwenzi in Repubblica Democratica del Congo) in cui uomini, donne e bambini vengono costretti a lavorare in condizioni terribili e sottoposti quotidianamente a sostanze nocive.
Particolarmente allarmante, però, è il fatto che queste tecnologie, per funzionare, hanno bisogno dei nostri dati e delle nostre informazioni private, che vanno in pasto ai grandi della tecnologia, che proprio sui nostri dati si arricchiscono attraverso pubblicità cucite su misura per noi e mirate a farci spendere e consumare prodotti in maniera compulsiva. È proprio su queste basi che Clive Humby afferma che “i dati sono il nuovo petrolio”: piattaforme come Amazon, Meta e Google guadagnano tanto più da noi quanto più sanno di noi. Applicando questo processo a miliardi di persone, si capisce come esse siano diventate realtà con un potere economico (e, di conseguenza, politico) inimmaginabile.
Per approfondire questi temi, suggeriamo la lettura del volume collettivo Ecologia digitale. Per una tecnologia al servizio di persone, società e ambiente (2022), edito e curato da Altreconomia.
A marzo 2025 i social network sono stati invasi dall’ennesima moda. Le bacheche di Instagram si sono riempite di milioni di ritratti, generati da intelligenza artificiale, che riprendono lo stile dello Studio Ghibli, casa cinematografica di animazione fondata da Hayao Miyazaki. Grazie a ChatGPT, adesso chiunque può diventare un personaggio de La città incantata (2001) nel giro di qualche minuto.
Certamente l’IA generativa fornisce degli strumenti utilissimi per la nostra vita lavorativa e interessanti fonti di intrattenimento da caricare sui social, ma ad essa si legano anche numerose criticità da non sottovalutare.
Innanzitutto, i prodotti dell’IA generativa hanno diverse criticità legate al copyright. Da un lato, essi non sono protetti da copyright e, in quanto tali, sono potenzialmente fruibili da chiunque. Dall’altro lato, si trova un problema ancora più grave: i database a partire dai quali queste tecnologie generano contenuti contengono anche innumerevoli opere di artisti, quasi sempre a loro insaputa.
In sostanza, si sta usando il lavoro di altre persone in maniera gratuita e senza il loro consenso. Dietro a quello che sembra un gioco, si nasconde in realtà un comportamento di dubbia eticità.
Sorvolando altre tematiche controverse sull’IA generativa, tra i quali il proliferare di deepfake, la problematica più grave rimane quella dei dati. Un’intelligenza artificiale è un modello statistico, cioè una macchina fatta per agire in base alle leggi della probabilità. Non c’è niente di intelligente in una IA, almeno non nel senso umano: essa è una macchina addestrata per compiere determinate azioni elaborando la richiesta (prompt) di un essere umano. E quanti più dati riesce a elaborare, tanto meglio riesce a soddisfare la richiesta.
Per questo motivo, le varie piattaforme devono raccogliere una mole sterminata di dati per addestrare l’algoritmo, e lo fanno col nostro consenso - anche se spesso non ce ne accorgiamo: d’altronde, chi legge mai i termini e le condizioni?
In conclusione, è necessario imparare a coltivare una relazione sana con il digitale, cogliendo le opportunità del digitale senza cadere in quello che Meredith Broussard, docente e data journalist americana, chiama “tecnosciovinismo”, cioè «la convinzione che la tecnologia sia sempre la soluzione» (La non intelligenza artificiale. Come i computer non capiscono il mondo, FrancoAngeli srl, Milano, 2019, p. 17).
Dobbiamo iniziare a adottare un approccio etico e critico, facendo nostre delle abitudini migliori e più salutari per noi come individui, come membri di una società e come abitanti di un pianeta in preda all’inquinamento. E, a questo scopo, il lavoro delle cooperative del Terzo Settore è fondamentale.
Una proposta fondamentale, in Italia, è quella di Sloweb. Fondata nel 2017, questa associazione si propone come movimento d’opinione nell’ambito di etica del web.
I loro scopi principali, come vengono riportati nel loro Manifesto, riguardano la promozione dell’uso responsabile delle tecnologie digitali, la trasmissione del sapere, accessibilità e inclusione delle persone con disabilità, il contrasto dei rischi legati al digitale e la tutela dei diritti fondamentali delle persone sul web. In sostanza, si tratta di «rendere il web più sicuro, libero e utile per tutti».
Gli strumenti con cui Sloweb porta avanti l’impresa sono:
Oltre al sito web, raccomandiamo anche la lettura di Sloweb. Piccola guida all’uso consapevole del web (2018), volumetto edito da Golem Edizioni e curato dai fondatori di Sloweb Pietro Jarre e Federico Bottino.
*Servizio civile digitale a Consorzio COeSO Empoli
Foto di Steve Johnson su Unsplash

27 Gennaio 2026
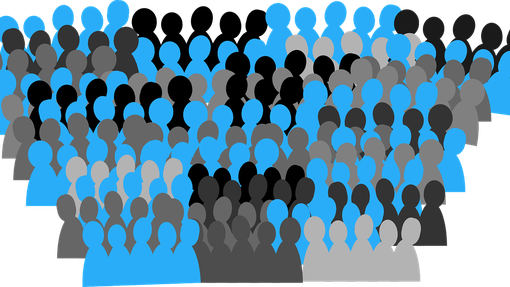
26 Gennaio 2026